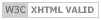3 maggio 2015 - V Domenica di Pasqua: rimanere in Lui per portare frutto
News del 01/05/2015 Torna all'elenco delle news
Ci stiamo avviando, lentamente ma in maniera decisa, verso la conclusione del Tempo di Pasqua, durante il quale stiamo gustando la presenza del Signore Risorto in mezzo ai suoi discepoli, in mezzo alla Chiesa nascente che lo annuncia vivo e presente nel mondo. Quando il Tempo di Pasqua terminerà, con la Pentecoste inizierà il Tempo della Chiesa, il tempo in cui, nell'ordinarietà e nella ferialità degli eventi, saremo chiamati a fare memoria della prima Comunità dei credenti che cammina senza più la presenza del Cristo risorto e vivo in mezzo agli uomini.
È questo il motivo per cui, in queste due domeniche, la Liturgia della Parola ci presenta la lettura di due testi tratti dal capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, che a ragione può essere considerato parte dei discorsi di addio di Gesù ai suoi discepoli, quelli pronunciati durante l'ultima cena, e a cui Giovanni dedica quasi un quarto del suo Vangelo!
In modo particolare, questo capitolo 15 è ricordato ed è famoso per la similitudine, potremmo dire la parabola, della vite e dei tralci. Giovanni non inventa nulla di assolutamente nuovo: più volte i testi dell'Antico Testamento, nella tradizione profetica, paragonano il popolo d'Israele a una vigna che è proprietà di Dio, il quale la custodisce e se ne prende cura con gelosia, anche quando - e non è infrequente, purtroppo - i frutti sperati non arrivano e di quel poco che produce "ogni viandante ne fa vendemmia".
Quello che è nuovo in Giovanni è una cosa che apparentemente può sembrare senza significato; ovvero, che rispetto alla tradizione veterotestamentaria Giovanni mette in bocca a Gesù una similitudine non basata sul rapporto "vigna-vignaiolo" (abbinato invece all'amore geloso di Dio verso il suo popolo) come simbolo del rapporto suo con i propri discepoli, ma su un rapporto ancora più forte, più immediato, più stretto, quello tra la vite e i tralci, tra l'albero e il frutto, tra il fusto che trasmette la linfa vitale e il grappolo che pende fruttuoso dal fusto...senza di lui, senza fare riferimento esclusivamente a Gesù Cristo, "non possiamo dare frutto". Serviamo solo a essere gettati via, tagliati da lui. Ma "tagliati" lo siamo pure nel caso in cui portiamo frutto, però attraverso il metodo della potatura, che sa dove tagliare perché quanto prodotto possa essere ancor migliore in futuro.
In definitiva, sembra dire Giovanni, o c'è comunione tra noi e il Maestro e tra noi stessi nella comunità dei credenti, o la nostra fede è inutile e improduttiva. Non ci si salva se non all'interno di una comunità; non si può sperare minimamente in un successo delle nostre attività pastorali se non perché siamo parte di una parrocchia, di una Chiesa locale, di un gruppo di persone che credono nella stessa fede. Questo non è affatto una dichiarazione di esclusivismo, di elite, di pastorale "del gruppetto" ("Basta che stiamo bene noi insieme, nel nome di Gesù, e il resto non importa", sembrano dire molti gruppi di credenti nelle più disparate esperienze religiose ecclesiali): è invece quello che ci viene detto e proposto dalla Chiesa degli Atti degli Apostoli, le cui gesta ci stanno accompagnando in questo Tempo Pasquale e di cui abbiamo ascoltato un bellissimo esempio anche nella prima delle letture di oggi.
Quella degli Atti è una Chiesa ben cosciente di avere un centro che ne rappresenta l'unità (la Chiesa di Gerusalemme), ma non per questo tralascia le periferie. In effetti, la prima preoccupazione di Paolo e Barnaba è di fare in modo che la comunità di Gerusalemme, che aveva conosciuto Paolo per altri motivi, non certo rassicuranti visto che era stato un convinto persecutore della Chiesa nascente, potesse rendersi conto della verità della sua conversione. Ecco allora l'urgenza di recarsi a Gerusalemme a farsi conoscere dalla comunità originale. Da lì, Paolo e Barnaba partiranno poi per annunciare il Vangelo in altre città e fondare nuove comunità di credenti.
Quello che è più interessante, però, è che la diffusione del Vangelo inizialmente non avviene per via di una definita strategia: ossia, dopo la Pentecoste, gli apostoli non si sono seduti a tavolino a fare una "programmazione pastorale" per dire dove si sarebbero recati ad annunciare il vangelo. Anzi: tutto questo avviene per un motivo completamente opposto, ovvero per via della persecuzione. A volte, è una persecuzione esterna alla Chiesa, condotta da parte dei pii ebrei nei confronti di questa nuova "setta" (com'erano visti i cristiani) che minava alla base l'unità della fede giudaica; in altre occasioni, la "persecuzione" è interna alla stessa comunità dei credenti.
È appunto il caso di Paolo, che subisce contrasti all'interno della comunità dei discepoli perché non credono ancora che egli fosse passato dalla parte del vangelo. Egli si ferma nella comunità di Gerusalemme, ma a causa delle discussioni che ne sorgono con un gruppo di discepoli, per evitargli problemi ulteriori viene fatto fuggire e viene nascosto nella sua città natale di Tarso. Lì poi Barnaba andrà a cercarlo per portarlo con sé ad Antiochia e nelle altre città destinazione dei loro numerosi e avventurosi viaggi.
Anche questa situazione, di apparente contrasto, non impedisce tuttavia al Vangelo di diffondersi e alla Chiesa di crescere numericamente. Come può avvenire questo, che ha tutta l'apparenza di qualcosa di miracoloso o comunque d'incomprensibile?
Avviene nella misura in cui i discepoli rimangono uniti tra di loro, uniti a Cristo e convinti di non essere loro i protagonisti della missione. Non sono loro che fanno in modo che la vigna dia frutto: "Senza di me non potete far nulla", ribadisce il Signore nel vangelo che abbiamo ascoltato. Insomma, nella Chiesa c'è poco da fare: tutto è opera di Dio. Anche l'impensabile e l'incomprensibile possono farsi realtà, in una comunità di credenti che rimane unita come il frutto al suo albero, come il grappolo alla vite.
Omelia di don Alberto Brignoli
Chi rimane in me porta molto frutto
Uno stesso tema riunisce i due testi di Giovanni (1 Giov.3,18-24; Giov.15,1-8) che la liturgia della domenica quinta di Pasqua ci presenta: occorre "rimanere" in Cristo per portare i frutti dell' Amore. Se con tanta forza è sottolineata l'urgenza per i discepoli di Gesù di portare frutti, che sono i frutti dell'Amore ("agape"), con altrettanta fermezza è dichiarato che questo è possibile solo "rimanendo" in Lui.
"Io sono il Pastore buono...", "Io sono la vite vera": continua così la Liturgia pasquale a farci rivivere il nostro incontro con Cristo risorto, vivo della vita di Dio, l' "Io sono", che può dare alla nostra vita il senso a cui aspiriamo dal profondo del nostro cuore.
L'allegoria della vite è familiare ai profeti di Israele: Osea, Isaia, Ezechiele, paragonano il popolo d'Israele alla vite piantata da Dio. Il testo più espressivo è il canto della vigna di Isaia 5,1-7: "Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna...Che cosa dovevo fare ancora per la mia vigna che io non abbia fatto?..." Ma il canto d'amore diventa di amara delusione: "Aspettò che producesse uva e invece produsse acini acerbi..."
Gesù riprende l'allegoria ma in modo radicalmente nuovo: all'opposto della vigna che non ha prodotto frutto, Gesù si presenta come Colui nel quale si realizza il progetto di Dio. Il Padre è il vignaiolo che ha piantato la vite e ad essa ha comunicato tutto il suo amore; Lui, Gesù, è la vite "vera": vera perché Lui porta il frutto atteso dal vignaiolo, Lui realizza il sogno per il quale aveva piantato la vigna. Gesù è il ceppo autentico, la vite autentica, e tutti i discepoli sono i tralci: la comunione di Gesù con i discepoli, una comunione intensa, ricca di vita, è la realizzazione del progetto del Padre. Ma questa realizzazione avviene perché il Padre stesso ha comunicato tutto se stesso al Figlio e il Figlio lo ha accolto, ha risposto con il dono totale di sé al Padre: senza questa relazione tra il Padre e il Figlio non ci sarebbe la fonte della linfa vitale di cui vive la Vite vera, che dal ceppo passa ai tralci perché essi portino frutti abbondanti. Tutto è Amore, tutto è comunione, tutto è vita: tutto è dono, donato, accolto, condiviso, e il cuore di tutto questo è Lui, Gesù con il suo abbandono totale nel Padre che fa di Lui la fonte dalla quale sgorga la vita per il mondo intero.
Certo, quando Gesù parla dei "frutti", fa riferimento al racconto della creazione: quando Dio crea l'erba e gli alberi dona loro la possibilità di produrre frutti e semi; gli animali e gli uomini sono chiamati a moltiplicarsi (Gen.1,11-12). Tutto ciò che è creato ha la possibilità a sua volta di portare la vita: la creazione è "buona", e questa vita che produce frutti è una benedizione di Dio. Ai suoi discepoli Gesù rivela che la vita vera che produce frutti maturi passa attraverso la sua unione con il Padre e dei discepoli con Lui.
Tutto è grazia, benedizione, meraviglia, splendore di vita: l'unica condizione è "rimanere in Lui". "Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me, non potete fare nulla..." La parola di Gesù, stupenda, rivelazione della gratuità del dono della vita offerta a chi "rimane" in Lui, come sempre nel Vangelo di Giovanni, è pure preoccupata, esigente, pedagogica. "Senza di me non potete fare nulla": il rischio fondamentale, legato alla dimensione umana come tale, è l'autosufficienza, il voler fare da sé, l'aver paura di Dio, di Cristo, quasi che il rapporto con Dio condizionasse la realizzazione dell'uomo. Cristo è l'offerta d'amore del Padre, perché chi "rimane in Lui" sperimenti la libertà e la pienezza della vita. Gesù certamente denuncia ogni attivismo puramente umano e l' illusione che l'autosufficienza possa condurre alla realizzazione della vita umana.
Quando Giovanni scrive, è cosciente dei rischi che la sua comunità sta correndo e vede all'opera il vignaiolo, il Padre, che "taglia" e "purifica", non per distruggere la vite, ma per permetterle l'abbondanza della vita.
Probabilmente Giovanni allude anzitutto, al rischio che la comunità dia per scontato il suo "rimanere in Lui" e diventi autoreferenziale, preoccupata più di quello che ritiene la propria testimonianza nel mondo che non di lasciare che Lui operi in lei. Sono in vista le persecuzioni: il pericolo è allora quello di scoraggiarsi, di dubitare dell'amore di Dio. Si tratta invece di "rimanere in Lui", nella logica della Croce: la comunità ne esce allora purificata e realizza la vite vera.
L'altro pericolo è il settarismo all'interno della comunità: l'evangelista ha senza dubbio in mente i membri della comunità che si sono separati (1 Giov.2,19), che hanno privilegiato prospettive, idee, modi di intendere propri, piuttosto che "rimanere in Lui", nell'unità della comunione fraterna. Non è il vigore di un tralcio che si separa dalla vite che dà la vita, ma è la vite che dà la vita atttraverso i tralci pur fragili: "senza di me non potete fare nulla".
"Rimanere in Lui", nell'unità per la quale Gesù ha pregato è dunque il valore fondamentale (Giov.17). Non per nulla il verbo "rimanere", caro al Vangelo di Giovanni, ritorna incessantemente in questo brano: dodici volte in pochi versetti. "Rimanere" non è soltanto essere "accanto" o "con" ma essere "nell'altro" e non significa un semplice "restare" statico oppure sentire l'obbligo di non abbandonare un luogo: esprime l'unione intima, l'inabitazione di Gesù nei suoi discepoli e dei discepoli in Lui, in una dimensione dinamica di relazione, di ascolto, di trasformazione interiore che genera poi la trasformazione di tutta la vita.
"Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto": il frutto atteso dal vignaiolo, che la vite vera produce, che realizza pienamente il suo sogno, dunque, è l'amore, la comunione, che fa dell'umanità un popolo unito, una comunità di fratelli.
"Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi": il rischio è di sottolineare soltanto la prima parte della frase riducendo l'invito di Gesù ad un impegno soltanto umano, psicologico. L'originalità del pensiero di Giovanni si esprime nella parola "come": non si tratta soltanto di imitare il Maestro che ha lavato i piedi dei discepoli, ma di agire come risposta all'amore che Lui ci dona per primo, con l'energia che Lui stesso dona ai tralci della vite.
Nel brano che la Liturgia ci fa leggere come seconda lettura (1Giov.3,18-24), Giovanni ci ricorda che l'amore non si limita a buoni sentimenti o a buone parole: "Figlioli, non amiamo a parole o con la lingua, ma con i fatti e nella verità". Immediatamente prima ha ricordato che la verifica della autenticità della mistica è il servizio dei fratelli.
Ascoltando la sua Parola e rivivendo nell'Eucaristia l'esperienza del "nostro" rimanere in Lui come Lui è in noi, sapendo che il nostro amore rimane sempre inadeguato al suo, gustiamo pure l'altra stupenda parola della seconda lettura, che ci illumina sulla dinamica fondamentale della nostra vita nella comunità credente: "Qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa".
Omelia di mons. Gianfranco Poma
Amore, coraggio, libertà, frutti di Dio
Nel brano tutto ruota attorno ad una immagine concreta e ad un verbo: la vite e dei tralci, il verbo «rimanere». Cristo vite, io tralcio: io e lui la stessa cosa! Stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. Lui in me e io in lui come figlio nella madre, madre nel figlio. Dio è in me, non come un padrone, ma come linfa vitale.
Dio è in me, come radice che invia energia verso tutti i rami. Dio è in me per prendersi cura più a fondo di me. In Cristo il vignaiolo si è fatto vite, il seminatore si è fatto seme, il vasaio si è fatto argilla, il Creatore si è fatto creatura. Non solo Dio con noi, ma Dio in noi. Se ci guardiamo attorno, conosciamo tutti delle persone che sembrano mettere gemme, le vedi germogliare e fiorire. E capisci che sono inserite in qualcosa di vivo!
Rimanete in me. Una sola condizione; non condizionamento, ma base della mia esistenza: nutrirmi della linfa della mia vite. Non sono parole astratte, sono le parole che usa anche l'amore umano. Rimanere insieme, nonostante tutte le distanze e i lunghi inverni, nonostante tutte le forze che ci trascinano via. Il primo passo è fare memoria che già sei in lui, che lui è già in te. Non devi inventare niente, non devi costruire qualcosa. Solo mantenere quello che già è dato, prenderne coscienza: c'è una energia che scorre in te, proviene da Dio, non viene mai meno, vi puoi sempre attingere, devi solo aprire strade, aprire canali a quella linfa.
All'inizio della primavera sui tralci potati affiora una goccia di linfa' che luccica sulla punta del ramo. Mio padre mi portava nella vigna dietro casa e mi diceva: è la vite che va in amore! Quella goccia di linfa mi parla di me e di Dio, dice che c'è un amore che sale dalla radice del mondo e mi attraversa; una vita che viene da Dio e va in amore, in frutti d'amore. Dice a me, piccolo tralcio: «Ho bisogno di te per una vendemmia di sole e di miele».
Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.
Il dono della potatura... Potare non significa amputare, significa dare vita, qualsiasi contadino lo sa. Rinunciare al superfluo equivale a fiorire. Perché gloria di Dio non è la sofferenza ma il molto frutto.
È come se Gesù dicesse: non ho bisogno di sacrifici ma di grappoli buoni; non di penitenze, ma che tu fiorisca. Nessuna vite sofferente porta buon frutto. Prima di tutto devo essere sano e gioioso io. Così Dio mi vuole.
Il nome nuovo della morale evangelica è «frutto buono», con dentro il sapore di Dio. Che ha il gusto di tre cose sulla terra: amore coraggio e libertà. Non c'è amore senza libertà, libertà non c'è senza coraggio. E amore libertà e coraggio sono la linfa e i frutti di Dio in noi.
Omelia di padre Ermes Ronchi
Liturgia e Liturgia della Parola della V Domenica di Pasqua (Anno B) 3 maggio 2015
tratto da www.lachiesa.it
 Home
Home